L'AMORE SECONDO LUCREZIO
Lucrezio, nel terzo libro de La natura delle cose, si occupa del fenomeno amoroso. “Così dunque chi riceve la ferita dai dardi di Venere, / […] / si protende verso la creatura da cui è ferito e arde / di congiungersi a lei, e di versare in quel corpo l’umore del proprio corpo. / Infatti la tacita brama presagisce il piacere” (vv. 1052 – 1057). Così, da Venere si viene colpiti, attraverso il corpo dell’amato. Masochisticamente, si aspira ad avere un contatto con la fonte della violenza a cui siamo soggetti. Si ambisce all’unione con essa. L’amore è un’esperienza di sofferenza, quando la tacita brama, cioè il desiderio, annuncia in anticipo l’evento futuro del piacere. La lontananza dell’amato produce nella mente dell’amante dei simulacri, delle immagini, dei fantasmi ossessionanti. Che fare, dunque? “Ma conviene che tali fantasmi si fuggano, che si ricusi / ogni alimento d’amore, ad altro il pensiero si volga, / e il seme raccolto si eiaculi in casuali amplessi, / né lo si serbi, una volta filtrato, a un amore esclusivo, / futura pena a se stessi e sicuro travaglio” (vv.1063 – 1067). Per evitare che l’amore sia doloroso, occorre: evitare le idealizzazioni; dedicare le proprie energie mentali ad altro; avere rapporti sessuali non legati al sentimento; non praticare la monogamia. Questo può apparire scandaloso. Lucrezio, infatti, precisa: “Non perde il frutto di Venere chi evita amore” (v. 1073). Chi separa il desiderio dal piacere, la volontà di possedere l’amato dal bisogno di avere rapporti sessuali, non si priva del piacere stesso. È, anzi, proprio la commistione di questi due elementi a generare sofferenza. Il filosofo-poeta descrive, per suffragare questa tesi, la furia che caratterizza gli amplessi: “Premono stretta la creatura che desiderano, infliggono dolore / al suo corpo, e spesso le mordono a sangue le tenere labbra, / la inchiodano con i baci, poiché il piacere non è puro, / e vi sono oscuri impulsi che spingono a straziare l’oggetto, / qualunque sia, da cui sorgono i germi di quella furia” (vv. 1079 – 1083). L’ardore distruttivo è causato dalla convinzione erronea che il nostro bisogno, una volta consumato il corpo dell’amato, possa estinguersi. Il rapporto sentimental-monogamico, legato al desiderio, viene accomunato, sbagliando, all’atto di mangiare o di bere, in cui l’assimilazione dell’oggetto (cibo o acqua) coincide con la soddisfazione dell’esigenza. Per l’amore è diverso: “amore è l’unica cosa nella quale più grande è il possesso, / più il cuore arde d’un desiderio feroce” (vv. 1089 – 1090). Nonostante la natura insaziabile del desiderio, l’amante tenta di mangiare il corpo dell’altro, assimilarlo, assorbirlo, facendolo sparire come succede con un tozzo di pane o con un po’ d’acqua. L’accoppiamento diventa, così, una lotta rabbiosa, che ha il fine di ottenere ciò che non si può ottenere. Gli amanti, infatti: “nulla possono distaccare dalla persona amata, né penetrarla né perdersi con tutte le membra nell’altro corpo” (vv. 1110 – 1111). L’amore richiede il sacrificio di un amante o dell’altro o di entrambi. Questo rito però non può compiersi. Di qui, la frustrazione, la tristezza, la sofferenza. Non rimane che il piacere fine a stesso che assume le sembianze di un bisogno semplice, non corredato di ulteriori patimenti. Lucrezio arriva a suggerire la pratica dell’amplesso slegato da dinamiche procreative, sentimentali o monogamiche e fa, quello che possiamo considerare, un elogio delle prostitute: “A proprio vantaggio le meretrici sogliono dimenarsi in tal modo, / per non incingersi spesso e giacere gravide, / e per rendere più gradevole agli uomini il piacere dell’amplesso; ma appare evidente che ciò non occorre alle nostre spose” (vv. 1274 - 1277).
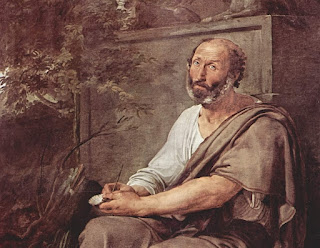



Commenti
Posta un commento